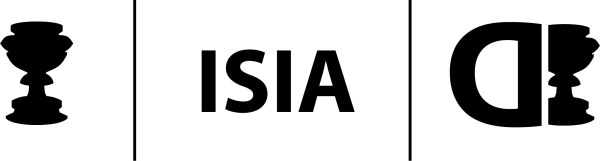Jennifer Guerra: «I social hanno normalizzato il femminismo. Sappiamo tutto, ma non come stare insieme»
La quarta ondata (in fase calante), la “brandizzazione” delle idee e una nuova terra di mezzo su cui lavorare. Una giovane scrittrice si interroga sul movimento femminista di oggi.
Articolo di Micol Sarfatti – Corriere 16.03.2024 (link – permalink) – Copia ai fini della conservazione e ricerca testuale
Cosa vuol dire essere femministe oggi? Quali battaglie si portano avanti e dove, nelle piazze o in Rete? Il femminismo, argomento sempre più caldo e discusso, non rischia di diventare una moda, anche commerciale, una posa svuotata dei suoi intenti primigeni? A queste e altre domande prova a rispondere Jennifer Guerra, giornalista e scrittrice, nel saggio Il femminismo non è un brand, edito da Einaudi. Guerra, 29 anni, appartiene alla generazione apparentemente più informata e consapevole sui temi di genere, ma, come ben analizza lei stessa, i passi da fare e i miti da sfatare sono ancora molti.
Oggi siamo in quella che viene definita la quarta ondata del femminismo. Da cosa è caratterizzata?
«La storia del femminismo si divide tradizionalmente in quattro ondate. La prima coincide con l’elaborazione teorica del femminismo e con l’attivismo per il voto alle donne e va dalla seconda metà dell’Ottocento agli Anni 20-30 del Novecento. La seconda ondata è quella a cavallo tra gli Anni 60 e 70, la terza tra gli Anni 80 e 90. La quarta è iniziata circa 10 anni fa, tra il 2013 e il 2014, in una prima fase, a mio parere, era caratterizzata da un dibattito molto più vivace. Una delle peculiarità della quarta ondata è il ruolo massiccio di Internet e dei social media, che hanno contribuito a diffondere il pensiero femminista su vasta scala, ma, allo stesso tempo, lo hanno appiattito, portando una polarizzazione su alcuni argomenti e idee importanti della pratica. Quando si arriva a raggiungere una platea così ampia si mescolano istanze molto diverse. Il femminismo di oggi tiene insieme un movimento radicale come Non una di meno, una politica liberale come Hillary Clinton e una pop star come Beyoncé. Credo che la quarta ondata sia avviata verso una fase discendente».
Quali sono le conseguenze di questo “allargamento”?
«Ad un certo punto ha prevalso l’aspetto economico, di stampo neoliberista, che ha inglobato tutto il resto. È uno schema già visto con altre sottoculture, nate per mettere in discussione il sistema, ma poi normalizzate. In questi ultimi anni il femminismo è stato spogliato di molti aspetti radicali, quelli che mettevano più in discussione il sistema, e ne sono stati esasperati quelli più innocui. Attenzione, non vuol dire siano negativi, ma semplicemente meno rivoluzionari e se diventano dominanti rischiano di far sparire tutto il resto».
Ad esempio?
«Il punto principale del femminismo odierno è la parità di genere, ma questo tradisce l’essenza stessa del femminismo che, in origine, avrebbe voluto un mondo senza potere. La parità può essere solo uno degli obiettivi del movimento, ma non ne esaurisce la definizione».
Sui social si fa un largo uso del termine “inclusivo” legato al femminismo. Eppure, allo stesso tempo, sembra ci siano sempre più paletti e giudizi su cosa sia “femminista” e cosa no, come se ci fosse un unico modello a cui aderire. Cosa ne pensa?
«È un argomento complesso, oggi molto dibattuto, ma non lo legherei solo al femminismo in cui c’è una spinta verso l’autodeterminazione, la libertà, anche nell’uso del proprio corpo, e l’identità, ma l’inclusività è, in un certo senso, una premessa. Quello che mi spaventa di più è il passo successivo: la moralizzazione del femminismo. L’idea che il biglietto di ingresso al movimento sia una sorta di impeccabilità è amplificata dai social, dove l’idea di perfezione, etica e estetica, esiste ed è pure celebrata e dove il pensiero femminista è stato spezzettato in decine di microbattaglie. Lo vediamo nelle shitstorm, le ondate di odio e insulti che travolgono una persona che ha compiuto un passo falso, rispetto ai canoni, dimenticandosi tutto quello che di buono e coerente ha fatto prima».
Qui torniamo all’idea di appiattimento e di neutralizzazione del conflitto di cui parlava prima.
«Il femminismo non nasce per creare una società omogenea in cui tutte le persone hanno le stesse idee, le stesse identità, lo stesso percorso. Anzi, questa è proprio l’antitesi del femminismo, perché è il modo in cui le donne sono state categorizzate per decenni: un gruppo di persone con le stesse idee, gli stessi pensieri, gli stessi desideri, le stesse aspirazioni».
Nel saggio Il femminismo non è un brand riflette sul termine “empowerment”, partendo dall’analisi fatta dalla giornalista americana Jia Tolentino nell’articolo del New York Times intitolato “Come l’empowerment è diventato qualcosa che le donne possono comprare». È un concetto molto utilizzato ma ambiguo.
«Si proprio perché nasce come alternativa al “power”, non è il potere diretto su qualcuno o qualcosa, ma il potere di fare qualcosa: non è mio, ma trasferito su qualcosa di esterno. Questa è una grossa differenza. Il problema è che oggi tutto è diventato “empowerment”, dalla carriera alla scelta di depilarsi o meno, e così viene meno il significato più profondo legato all’autodeterminazione e alla capacità di riscatto. Torniamo ancora al rapporto complesso del femminismo egemonico con il potere» .
In che senso?
«Alla fine molte donne vogliono anche solo un briciolo di potere per esercitarlo in un modo che non si discosta da quello tradizionale. Così si ripete all’infinito un modello identico, cambia solo la persona che lo amministra». Si è diffuso un tipo di femminismo, in qualche modo figlio dell’empowerment, che insiste molto sul concetto di “se vuoi puoi”, “ogni obiettivo è raggiungibile se davvero ti impegni”.
Così però ci si dimentica delle disparità sociali, le condizioni di partenza non sono le stesse per tutte.
«Esiste una sorta di femminismo magico per cui tutto è possibile, purtroppo però il sistema è rotto da tempo e non permette, nella maggior parte dei casi, di compiere un vero percorso di emancipazione. Nel libro cito il caso di Sophia Amoruso, imprenditrice e fondatrice del marchio di abbigliamento Nasty Gal e fiera inventrice del termine Girlboss , coniato per definire una donna ambiziosa e di successo, soprattutto economico, che si è fatta da sola. Nel suo libro #GirlBoss , a metà tra l’autobiografia e il manuale di auto aiuto, racconta la sua favola di affermazione sociale e culturale in cui il patriarcato è un nemico astratto ma non spiega mai, ad esempio, come paga l’affitto o chi l’ha sostenuta nel suo percorso. Nel 2016, dopo la bancarotta della sua azienda, molti dipendenti hanno rilasciato interviste in cui denunciano una cultura del lavoro tossica portata avanti da una leader dispotica, pronta a licenziare donne in gravidanza. Questo “femminismo magico” si lega con la sindrome dell’impostore, una percezione di inadeguatezza molto diffusa, soprattutto tra le più giovani. Non ci si sente all’altezza di quello che si fa, quando magari, quello che manca, è una rete di sostegno o il supporto agli studi. L’impostore non sei tu, ma il sistema che non ti ha permesso di realizzarti pienamente perché non avevi i mezzi materiali».
Sempre più persone, soprattutto nel mondo femminista, si definiscono e qualificano come attiviste. Lei invece tiene a essere identificata come giornalista e scrittrice, perché? La sua è quasi un’eccezione…
«La parola attivista non ha nulla di problematico, premetto, ma ha sempre più a che fare con un’idea di femminismo vicina al personal branding, il posizionamento personale, e così diventa surrogato di una professione. Da qui arrivano pure le aziende che fanno pinkwashing cercando gli attivisti per coinvolgerli in collaborazioni di marketing. Non mi piace l’idea che l’attenzione verso un’azione collettiva si sposti su una singola persona. Rischia di diventare un santino sulle cui spalle pende il peso di tutta la lotta e, se sbaglia, trascina con sé tutte le altre persone associate alla causa. Non succede solo con il femminismo, l’identificazione delle battaglie con un singolo, elevato a esempio di sacrificio e di coerenza estrema, è sempre problematica e non corretta».
Quale femminismo si augura di vedere nei prossimi anni?
«Il femminismo è fatto di persone, deve confrontarsi continuamente con un contesto sociale in evoluzione. Non è facile fare previsioni e l’idea non mi piace. Vorrei però immaginare un movimento che abbia più a cuore la dimensione collettiva, con una pluralità di voci e una conflittualità positiva. Dobbiamo tornare a riflettere sul potere e recuperare alcuni punti della pratica femminista degli Anni 70, per me virtuosa, come il mutualismo. È questa la terra di mezzo su cui lavorare, oggi abbiamo accesso a tantissime letture, riempiamo le piazze e la spinta dei social resta comunque importante. Vorrei veder crescere una rete di centri sul territorio dove si incentiva il dialogo e si costruiscono relazioni guardandosi negli occhi».